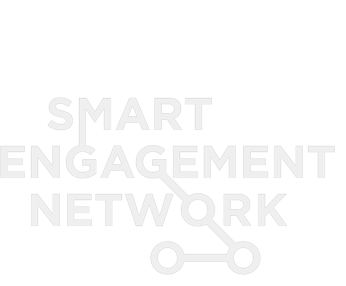I social media e la ricerca della relazione perduta
Torniamo alla Samuel, perché nella sua risposta potrebbero esserci spunti di riflessione interessanti. A un certo punto, lei scrive che
“preoccuparsi del fatto che i giovani scelgano di vivere molto online significa osservare uno stile di vita digitale emergente attraverso un prisma generazionale e presumere che le uniche conversazioni significative e degne di nota siano quelle con cui noi siamo cresciuti”.
Chi ha qualche anno in più di loro guarda a questi giovani con preoccupazione per la qualità delle conversazioni – e quindi delle relazioni sociali – che saranno in grado di avere nella loro vita: riusciranno ad avere un rapporto vero con qualcuno, come faranno a imparare ad ascoltare o a farsi ascoltare? Ogni volta che la incontro, questa demonizzazione mi preoccupa sempre un po’, perché mi trasmette la sensazione di un bisogno di giudicare più che di una voglia di approfondire un fenomeno nuovo. Il ragionamento che fa Samuel la porta a invitare tutti a una sorta di auto-riflessione sul modo in cui possiamo dare forma alle nuove relazioni digitali, assumendoci la responsabilità di forgiare con la qualità della nostra presenza online la vita digitale nel suo complesso.
Oggi, ho letto un altro articolo preoccupato: Che fine ha fatto la conversazione a due?, di Elvira Serra, pubblicato su La ventisettesima ora. Il pezzo apre con due giovani e belli (perché poi caratterizzarli così? Forse per riaffermare che l’incomunicabilità è un problema generazionale?) che si trovano “fuori a cena con lo smartphone sul tavolo, presenti e assenti nello stesso momento.” Leggendo, scopro che l’articolo nasce dallo stesso pezzo del NYT, cui si aggiunge un ulteriore tassello, questa volta preso dall’edizione americana di Wired, dove Marko Ahtisaari (responsabile della Design Unit di Nokia, una roba seria che copre sia la progettazione di prodotto che la user experience), racconta di una coppia che festeggia San Valentino al ristorante (di nuovo):
“Erano assorbiti dal touch screen del proprio smartphone anziché l’uno dall’altra. Il continuo evolversi dei telefonini, con schermi sempre più grandi e innumerevoli contenuti, catturano completamente la nostra attenzione isolandoci da ciò che ci circonda e facendoci vivere un’esperienza mobile completamente “immersiva”. Per me, invece, è importante che le persone si guardino negli occhi sempre, non perdano un solo istante di socialità. Qualcosa va migliorato”.
Leggere questi articoli mi ha fatto pensare al mio lavoro che è occuparmi di ascolto e relazioni fra le persone. Lo faccio all’interno delle organizzazioni e sono sempre più convinta, alla luce della mia esperienza, che possiamo parlare a lungo di strategie di sviluppo, riorganizzazioni aziendali, gestione del cambiamento all’interno delle organizzazioni (tutte cose vere e reali, su cui vale la pena lavorare ogni giorno), ma alla fine quello in cui le persone vanno accompagnate è imparare a parlarsi fra loro, senza farsi limitare dai rispettivi ruoli e dalle convinzioni limitanti proprie e altrui che le vorrebbero far agire e comunicare secondo modalità prestabilite e immobili.
Volete sapere una cosa? Nonostante trascorrano la propria vita professionale a stretto contatto fisico con colleghi, superiori e sottoposti, la cosa che trovano più difficile chiedere le persone (anche quelle che trascorrono una porzione minima se non nulla della propria vita online) è sempre la stessa: “come stai?”. Come se comunicassero con un estraneo che sta seduto davanti alla sua tastiera, dall’altra parte di uno qualunque degli oceani della terra. Non parliamo poi dei drammi che nascono dall’incapacità di dire a qualcuno in carne e ossa, che ci fissa dritto negli occhi, che ha fatto o detto qualcosa che abbiamo trovato sconveniente, inappropriato, sbagliato. Quando viene dato, questo tipo di feedback, viene dato male, spesso con l’unico scopo di colpire la persona per quello che è e non per quello che fa, andando a intaccare la sfera personalissima dell’identità e non quella dei comportamenti, unico territorio entro cui ci dovremmo muovere se ci troviamo all’interno di un’organizzazione. Credo di evocare situazioni famigliari a tante, tantissime persone. Spesso, le stesse che si preoccupano dell’incomunicabilità prodotta da un’intensa vita digitale.
Per cui, mi sento di invitarci ad assumere un angolo prospettico diverso: la prossima volta che ci verrà la tentazione di guardare nostro figlio o il ragazzino sull’autobus che twitta o comunica in altro modo con quelli che per noi non saranno mai amici veri, all’interno di relazioni che non capiamo fino in fondo, invece di scuotere (anche metaforicamente) la testa e pensare che si sta perdendo qualcosa di magico e irripetibile che noi abbiamo avuto e che ci ha fatto diventare quelli che siamo, proviamo a farci un’esame di coscienza. Forse, la tecnologia sta cambiando le nostre relazioni sociali, i concetti stessi di dialogo, ascolto e amicizia.
A ben guardare, non è poi detto che sia solo un male.
I contenuti di questo post, pubblicato in origine sul mio blog Oscilloscopio azzurro, sono rilasciati con licenza Creative Commons 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0). L’immagine in evidenza è stata realizzata da Peter DaSilva e Byron Smith per il «New York Times».