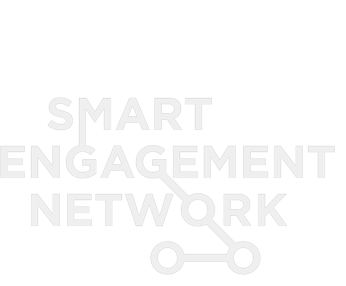Quando il silenzio è d’oro e come capirlo
Mi capita spesso di tenere corsi su come si parla in pubblico, dove con “pubblico” si intendono tante cose: un’ampia platea, un gruppo di colleghi in riunione, i selezionatori durante un colloquio d’assunzione, chi segue il nostro webinar online, ecc.
Oltre che di lavoro, si tratta di una vera e propria passione: l’argomento mi ha sempre interessata e, crescendo, mi sono chiesta a lungo e come tante persone quale fosse il segreto per conquistare un pubblico. Che atteggiamento assumere? Come tenere le mani? Dove guardare? Osservavo con attenzione il modo di presentarsi o di esporre un argomento di ogni tipo di persona, dallo speaker di mestiere al relatore di convegni, dal presentatore televisivo ai personaggi dei film, dal politico all’avventore del bar che raccontava una storiella divertente, chiedendomi quanto ci fosse (in quelli bravi) di innato e quanto invece di costruito. Ricordo ancora lo stupore provato, tanti anni fa, nello scoprire l’esistenza di canali diversi di espressione (verbale, non verbale e paraverbale) e il fatto che ciascuno di noi recepisce e assorbe ciò che gli viene trasmesso in modo diverso, a seconda che sia più sensibile alle immagini (visivo), alle informazioni (auditivo), alla dimensione sensoriale (cinestesico), ma anche ai propri modelli caratteriali.
Più studiavo e sperimentavo e meno mi preoccupava la questione da cui tantissime persone sono assillate. Ogni volta che mi trovo in un’aula a fare palestra di public speaking, c’è qualcuno che dice “Cosa devo dire?” e si stupisce quando rispondo che non lo so, che dipende dalla persona, da quello che vuole trasmettere, dal suo stile, dalla tipologia di persone che si trova davanti, ecc., insomma da tutta una serie di variabili che vanno valutate di volta in volta e che, messe assieme, poco assomigliano alla formula magica di cui moltissimi vorrebbero essere messi a parte.
In altre parole, comunicare è faticoso e richiede un grande sforzo di lettura e comprensione di noi che parliamo, del contesto e di chi lo abita.
In realtà, però, una delle questioni più sottovalutate quando si tratta di public speaking e di comunicazione in generale è quella di ciò che “non va detto” cioè quando è meglio scegliere di tacere.
Per quanto banale possa sembrare, è importante ricordare che una frase o un discorso non sono come un testo scritto. Digito una parola che non mi piace? Non c’è problema, la posso sempre cancellare. La parola non te la puoi rimangiare. Puoi morderti la lingua, darti del cretino, pentirtene appena è uscita dalla tua bocca, ma non servirà a nulla. Una volta detta è detta e il bene (o il male) che può fare al mondo non dipende più da noi. Ecco perché è importante fare un esercizio continuo di consapevolezza sulle parole che scegliamo di condividere.
Come si fa? Facendosi delle buone domande. Ve ne consiglio 3, che hanno a che vedere – rispettivamente – con obiettivi, contingenza e ruolo e che, nella mia esperienza, funzionano molto bene, anche quando interagiamo sui social:
1. Il mondo ne ha proprio bisogno?
C’è già tanto rumore nel mondo, perché contribuire a generarne di nuovo? In altre parole, ciò che sto per dire è di qualche utilità e aggiunge valore alla conversazione, al dibattito, alla conversazione, alla mia presentazione oppure rischia di essere ridondante o, peggio, di risultare inappropriato od offensivo per qualcuno?
Un buon modo per rispondere a questa domanda è, paradossalmente, ponendosene un’altra: per quale motivo reale voglio dire questa cosa? “Per dimostrare che ne so più degli altri e che ho una cultura enciclopedica”, “per far colpo sulla bionda in prima fila o sul mio capo” o, più genericamente, “per far capire a tutti quanto sono bravo/a” sono tutti motivi legittimi e rispettabili, ma non ci aiuteranno. Se il nostro vero obiettivo non è comunicare qualcosa che possa essere interessante per chi ci ascolta (e da lì, una parola dopo l’altra e un comportamento dopo l’altro, costruire la nostra reputazione), è probabile che non risulteremo efficaci. Dobbiamo esserne consapevoli che una buona comunicazione parte sempre da una chiarezza sugli obiettivi che vogliamo raggiungere, ma anche che il venditore a tutti costi non convince più nessuno.
2. È il momento giusto?
Può darsi che la risposta alla prima domanda sia stata affermativa, ma questo non significa che quello che abbiamo scelto sia il momento giusto per parlare. Questa domanda può tornarci utile soprattutto nei momenti delicati della vita professionale, per capire – ad esempio – quando dare un feedback a un collega, gestendo nel modo migliore l’eventuale presenza di altre persone o curando il contesto più adatto a trasmettere un certo tipo di messaggio, o quando vorremmo condividere un dubbio o una perplessità su un nuovo progetto e non ci interroghiamo abbastanza sull’effetto che le nostre parole potrebbero produrre nei colleghi o nei collaboratori. Un consiglio? Non agiamo d’impulso: rimediare a un errore comunicativo costa sempre più fatica che evitare di commetterlo.
3. La cosa che sto per dire sta a me dirla?
Tutti noi abbiamo opinioni, convinzioni o consigli da dare su come riteniamo andrebbero fatte le cose, ma un parere non è quasi mai recepito in modo neutro, in modo indipendente da chi lo esprime. L’opportunità di esprimere pareri e la capacità di proporre idee che verranno ritenute valide dipendono molto dal ruolo che rivestiamo in un determinato contesto.
Se non ne teniamo conto rischiamo di generare effetti controproducenti e il nostro messaggio, per quanto appropriato, cadrà nel vuoto. Tolto l’esempio scontato dei contesti di lavoro, in cui è evidente che fa molta differenza se a riprendere un collega che ha fatto qualcosa di sbagliato (e non risponde a me) sono io o il suo superiore, ci sono i casi della vita privata che a tutti noi sarà capitato di vivere: uno per tutti, i figli degli altri. Alzi la mano chi non ha avuto mai la tentazione di sgridare un bambino non suo, pur in presenza dei genitori. Chi l’ha fatto sa bene è probabile che abbia imparato a proprie spese che non conviene: l’insegnamento non viene recepito dal bambino se a impartirlo non è una figura per lui autorevole (senza contare che gli stessi genitori possono non essere molto felici dell’intromissione).
Provate per qualche giorno: scoprirete che, nella maggior parte dei casi, la risposta a queste 3 domande è quasi sempre no. Agite di conseguenza e scoprirete quanto è più efficace (e rilassante) non doversi pentire di qualcosa che abbiamo detto per i motivi sbagliati.
I contenuti di questo post sono rilasciati con licenza Creative Commons 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0).